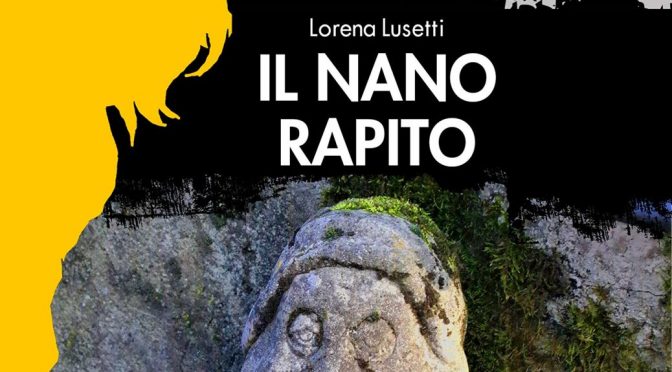Quando ho letto il titolo del libro del mio amico Marco Mastacchi, il mio primo pensiero è stato: dovrei rispondergli con un “Non volevo fare il dipendente comunale“.
Per chi non lo sapesse, Marco per dieci anni è stato sindaco di Monzuno, a partire dal maggio 2009. Periodo che è coinciso in buona parte con la mia esperienza alle pendici di Monte Venere (io arrivai come dipendente nel dicembre 2009 e lasciai il Comune nello stesso periodo del 2020).
In questo interessante libro autobiografico Marco Mastacchi ripercorre le tappe della sua esperienza amministrativa, in un viaggio in cui lettore è accompagnato a scoprire il difficile ruolo di primo cittadino nei piccoli comuni, per di più in montagna (Monzuno ha più o meno 6500 abitanti, in parte a 600 metri sul livello del mare, in parte nelle due vallate di Vado e Rioveggio). Perché dovete sapere – qui apro e chiudo una breve parentesi, il resto lo racconterò se davvero scriverò un libro su quegli anni – che per il legislatore italiano, fatte alcune limitate eccezioni, gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità sono gli stessi sia che tu amministri un ente con migliaia di dipendenti, sia che debba arrangiarti con una trentina di indomiti eroi. Ed è una follia.
Detto questo, del libro di Marco ho individuato tre principali direttive. La principale si sofferma, come sarebbe facile attendersi, sulla sua idea di politica. Marco rivendica il suo principio per cui un sindaco debba lavorare per risolvere i problemi dei suoi cittadini libero da orpelli ideologici. Nella sua visione asfaltare le strade o trovare i soldi per sistemare una palestra scolastica non è questione di destra o sinistra, ma di buon senso e buona amministrazione. Che poi è la cifra dei suoi movimenti politici civici: in Comune prima e in Regione dopo, dove è stato eletto consigliere regionale, Mastacchi si colloca in un centrodestra critico ma “collaborativo”, che non alza steccati pregiudiziali nei confronti delle proposte della maggioranza. Ad ogni modo, chi volesse piò approfondire questa prospettiva politica leggendo il libro: come Marco ben sa, ho sempre rivendicato il principio per cui l’addetto stampa non è il portavoce del politico, non comincerò certo adesso a smentirmi.
La seconda colonna portante riguarda le esperienze, le vicende di quegli anni, dalle nevicate di mezzo metro ai tagli per far quadrare i bilanci.
Marco racconta notti passate nella caserma dei carabinieri nei giorni in cui – e succede più spesso di quanto non dovrebbe – rappresentavano, grazie ai generatori, l’unico ambiente pubblico in cui si riusciva a operare. A causa delle forti nevicate, infatti, capitava di sovente che mancassero corrente elettrica e gas a causa di qualche traliccio caduto, Neanche i telefoni funzionavano, ci sentivamo qualche volta al giorno via sms e da lì informavo giornali e televisioni dell’evolversi della situazione.
Ci furono poi i giorni della camminata a piedi fino a Roma: una forma pacifica di protesta in cui il sindaco chiedeva all’allora governo Renzi di allentare la stretta sugli enti locali. Sostenuto anche da parecchi sindaci di centrosinistra. Stretta che, aggiungo io, negli ultimi due anni è tornata a fare male più che mai sulle amministrazioni locali.
E poi il crollo della palazzina a Vado nel maggio del 2010. Lo ricordo bene perché per un fine settimana ero tornato in Puglia per un matrimonio, le prime vacanze da quando lavoravo in Comune, e quando rientrai mi ritrovai la Rai e Sky con le loro dirette a raccontare la vicenda. Per fortuna non ci furono vittime perché l’edificio era stato sgombrato per tempo.
Forse è questa la parte più bella del racconto, senza nulla togliere alle altre, ma è perché dalle vicende di vita vissuta che si capisce cosa voglia dire indossare la fascia tricolore oggi. Personalmente mi vengono in mente tanti altri episodi che avrebbero meritato di essere narrati, in alcune circostanze mi sono trovato a pensare: ma come, ti fermi qui? E non racconti invece di quello che successe poi? Ma queste sono reazioni legate al fatto che in quelle località ho lavorato per undici anni.
La terza parte è quella che occupa i primi capitoli, ma che a me è parsa poi l’ossatura di tutto il libro e forse, azzarderei, del credo amministrativo e politico stesso di Marco Mastacchi. Marco rivendica con orgoglio che si possa essere antifascisti e conservatori, o moderati, o liberali, ditela come volete. In effetti è un peccato che una parte fondamentale degli eredi degli antifascisti (i cattolici, gli azionisti, i liberali, persino i monarchici) sembrino aver dimenticato le loro origini, finendo per mescolarsi con gli eredi di quelli che tifavano per Hitler. E facendo sì che l’antifascismo diventasse prerogativa di una parte, la sinistra, unica oggi a rivendicarne i valori. Se il 25 aprile oggi è da qualcuno considerato divisivo, è proprio perché si dimentica il contributo fondamentale di tanti italiani non di sinistra.
Anche in questo caso il libro – che non è certo un trattato sociologico – parte da una vicenda che ha toccato da vicino Marco Mastacchi: dopo l’8 aprile suo padre fu infatti internato in un campo di concentramento in Germania, come accadde a tanti italiani che improvvisamente si ritrovarono senza una guida. Il cugino di suo padre, Gino Mastacchi, uno dei sopravvissuti alla tragica spedizione in Russia dell’Armir, fu invece un partigiano. E che partigiano, verrebbe da dire: militava infatti nella brigata Stella Rossa, dove faceva infatti da interprete al mitico Karaton, soldato partigiano che guidava una truppa di una quarantina di sovietici che combatterono i nazisti in Appennino, fino all’eccidio di Monte Sole.
Marco non si vergogna affatto di queste parentele, anzi ne scrive con giusto e motivato orgoglio.
Il giorno che l’antifascismo sarà un valore di tutti, destra e sinistra, e non un randello da usare contro gli avversari quando non si hanno argomenti migliori, sarà un gran giorno per la democrazia italiana. Chissà se Marco e io vivremo abbastanza per vederlo, quel giorno. Le prospettive non sono delle migliori.
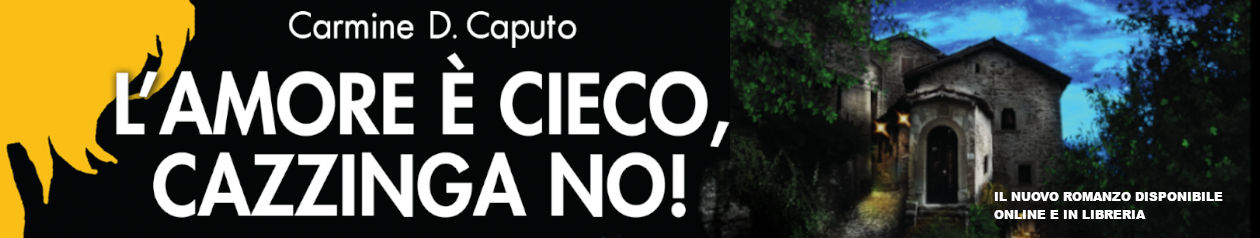

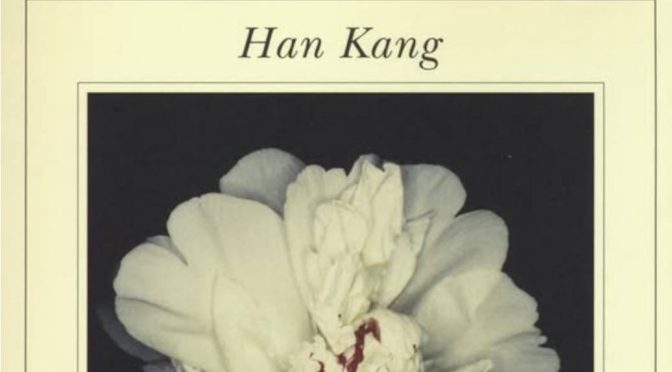

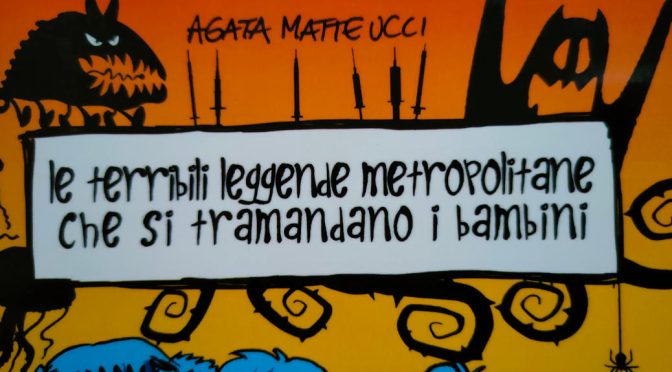
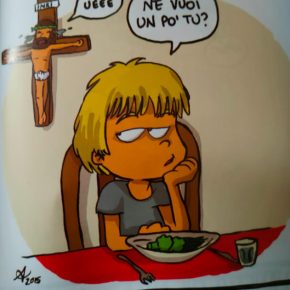 per i libri ho sempre provato un sentimento di affetto, quelli che mi fanno ridere li amo davvero. La risata provocata dalla parola scritta, o dal fumetto, ha una potenza generata dal percorso tortuoso che porta all’esplosione. Il cervello riceve il messaggio, lo codifica, coglie l’allusione, annuisce e muove la leva magica: ok gente, qui c’è da ridere. Sono molto curioso a tal proposito di capire se l’intelligenza artificiale sarà mai capace di fare buone battute. Dubito. Al limite potrà replicare strutture alla base del linguaggio comico, ma una battuta è un guizzo di genio, non è l’esito di un algoritmo.
per i libri ho sempre provato un sentimento di affetto, quelli che mi fanno ridere li amo davvero. La risata provocata dalla parola scritta, o dal fumetto, ha una potenza generata dal percorso tortuoso che porta all’esplosione. Il cervello riceve il messaggio, lo codifica, coglie l’allusione, annuisce e muove la leva magica: ok gente, qui c’è da ridere. Sono molto curioso a tal proposito di capire se l’intelligenza artificiale sarà mai capace di fare buone battute. Dubito. Al limite potrà replicare strutture alla base del linguaggio comico, ma una battuta è un guizzo di genio, non è l’esito di un algoritmo.