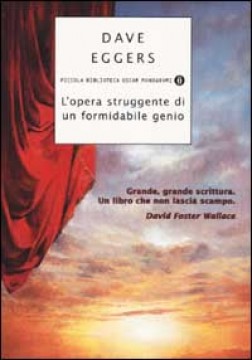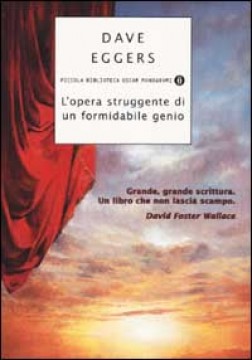 Questo romanzo fa cagare. Ecco. L’ho detto. Natale è passato, possiamo anche essere un po’ meno buoni e dire le cose come stanno. Certo avrei potuto dire semplicemente che non mi è piaciuto, che è troppo lento, che le divagazioni stancano, sono poco interessanti e manifestano solo il delirio egocentrico dell’autore, che si identifica nel protagonista essendo il romanzo autobiografico. Ma non basta, perchè questo è vero di tanti romanzi, ma non tutti riportano in copertina la frase “Grande, grande scrittura. Un libro che non lascia scampo ” (a proposito, chi è il Wallace che ha dato questo commento? Devo scoprirlo).
Questo romanzo fa cagare. Ecco. L’ho detto. Natale è passato, possiamo anche essere un po’ meno buoni e dire le cose come stanno. Certo avrei potuto dire semplicemente che non mi è piaciuto, che è troppo lento, che le divagazioni stancano, sono poco interessanti e manifestano solo il delirio egocentrico dell’autore, che si identifica nel protagonista essendo il romanzo autobiografico. Ma non basta, perchè questo è vero di tanti romanzi, ma non tutti riportano in copertina la frase “Grande, grande scrittura. Un libro che non lascia scampo ” (a proposito, chi è il Wallace che ha dato questo commento? Devo scoprirlo).
Lo spunto di partenza è drammatico e interessante: tre fratelli e una sorella si ritrovano in pochi mesi la vita sconvolta dalla scomparsa per cancro dei due genitori. Le poche pagine non dico belle ma almeno di una qualche dignità letteraria sono proprio quelle dedicate agli ultimi giorni della madre dell’autore. L’autore e il fratello minore chiudono allora i ponti con Chicago, la loro città natale, e si trasferiscono in California.
E poi non succede più niente, perché per centinaia e centinaia di pagine è solo il continuo vaniloquio del protagonista che schiaccia gli altri personaggi, li riduce a macchiette quando non a semplici spalle del “formidabile genio”, uno che ci ammorba con discorsi insulsi che non conclude mai e con una scrittura che dovrebbe far ridere tutte le volte che ripete il turpiloquio in maniera ossessiva ma che già la terza volta stanca. Ho fatto una fatica indicibile a terminare questo romanzo, ma ci tenevo a farlo perché prima di stroncare un’opera bisogna essere sicuri che davvero non ci sia, su 369 pagine, almeno una frase degna di nota. E non c’è, ve lo assicuro. A parte il titolo, che è veramente bello, e che riesce a battere persino “La solitudine dei numeri primi” per contrasto tra un titolo promettente e una storia fiacca e deludente.